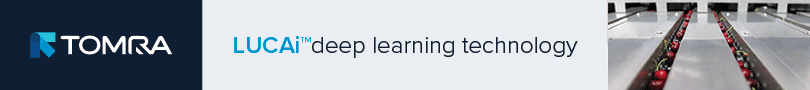Il cambiamento climatico a cui ci troviamo di fronte oggi genera incertezza riguardo alle condizioni climatiche di ogni stagione. Abbiamo osservato come le temperature e le precipitazioni annuali varino considerevolmente di anno in anno, obbligandoci a restare vigili e ad adattare le strategie produttive stagione dopo stagione.
Per quanto riguarda il fabbisogno di freddo invernale delle specie a foglia caduca, le zone a clima temperato affrontano oggi una grande sfida: l’aumento delle temperature invernali, dovuto al cambiamento climatico, rappresenta una minaccia crescente per la sincronizzazione del ciclo fenologico di queste colture.
La mancata o insufficiente accumulazione di freddo – sempre più frequente – ostacola l’uscita dalla endodormienza, causando germogliamento irregolare, fioritura disomogenea, riduzione dell’allegagione e calo della qualità e quantità produttiva. Nel ciliegio, ad esempio, la carenza di freddo ha portato a una germogliazione parziale, minore allegagione e cali di resa.
Inoltre, l’esposizione a eventi di caldo precoce può indurre una fuoriuscita anticipata dalla dormienza, aumentando il rischio di danni da gelate tardive.
Strategie e modelli per affrontare il cambiamento
In risposta a questo, si stanno sviluppando modelli fenologici più accurati che integrano dati climatici in tempo reale e parametri genetici per prevedere con maggiore affidabilità la dinamica della dormienza.
Parallelamente, si lavorano strategie di miglioramento genetico, insieme a pratiche agronomiche come l’uso di cianammide idrogenata, l’applicazione di biostimolanti, l’impiego di reti ombreggianti e altri strumenti per compensare la carenza di freddo invernale nelle specie adattate a climi temperati.
Tuttavia, non sempre queste tecniche o strategie si dimostrano efficaci, poiché le condizioni climatiche – soprattutto in autunno e inverno – variano di anno in anno e da zona a zona.
Per questo, è fondamentale comprendere i fattori chiave che regolano l’entrata, la permanenza e l’uscita dalla dormienza, nonché cosa accade all’interno delle gemme durante questo periodo.
La dormienza e il suo funzionamento
La dormienza è una strategia fisiologica essenziale per i fruttiferi coltivati in climi temperati, utile per sopravvivere alle condizioni ambientali avverse, in particolare al freddo invernale.
Questo processo avviene in due fasi principali: endodormienza (entrata) ed ecodormienza (uscita), entrambe fortemente regolate da fattori ambientali come temperatura, fotoperiodo e, in misura minore, disponibilità idrica e stress abiotico.
Entrata nella dormienza (induzione)
L’entrata in dormienza è indotta principalmente dalla riduzione del fotoperiodo e dal calo progressivo delle temperature in autunno. Questi segnali sono percepiti da recettori specifici nei tessuti meristematici e scatenano una cascata di risposte ormonali, in particolare l’aumento dell’acido abscissico (ABA) e la repressione delle gibberelline (GA), che bloccano la crescita cellulare e promuovono lo stato di dormienza.
In specie come Malus domestica e Prunus avium, si è osservato che la percezione anticipata dei giorni corti attiva geni della famiglia DAM (Dormancy-Associated MADS-box), che agiscono da principali regolatori della dormienza.
Durante la transizione verso l’endodormienza, una delle risposte cellulari più rilevanti è l’accumulo di callosio (β-1,3-glucano) nei plasmodesmi, strutture che collegano le cellule attraverso le pareti. Questo accumulo riduce la connettività cellulare, agendo come barriera al passaggio di segnali, metaboliti e ormoni.
Le funzioni della callosa includono l’isolamento del meristema apicale, la riduzione della permeabilità delle membrane, la limitazione del trasporto intercellulare di ormoni promotori della crescita (come le gibberelline) e la protezione da stress abiotici, ostacolando la diffusione di patogeni o segnali di danno.
La sintesi di callosa è stimolata dal fotoperiodo breve e dalle basse temperature, in concomitanza con l’espressione dei geni DAM e l’aumento dell’ABA.
Uscita dalla dormienza
L’esposizione prolungata al freddo innesca modificazioni fisiologiche e molecolari che portano alla disattivazione dei geni DAM. In specie come Prunus persica e Prunus avium, l’accumulo di freddo riduce progressivamente l’espressione di questi geni, permettendo lo sviluppo delle gemme.
Con il progredire dell’inverno, la callosa viene degradata da enzimi come β-1,3-glucanasi, ripristinando la comunicazione tra le cellule tramite i plasmodesmi. Questo è un passaggio fondamentale per riattivare il metabolismo delle gemme, la divisione cellulare e il germogliamento.
Il freddo modifica anche il bilancio ormonale: i livelli di ABA diminuiscono, mentre le gibberelline aumentano, stimolando la crescita cellulare. Sono stati osservati anche meccanismi epigenetici, come la metilazione del DNA e modificazioni istoniche, che partecipano alla regolazione della dormienza in risposta al freddo.
La transizione verso l’ecodormienza, e infine verso la ripresa vegetativa, avviene quando le temperature iniziano a salire e si accumulano gradi-giorno sopra una soglia termica. In questa fase aumentano gibberelline, citochinine e auxine, che stimolano il metabolismo e l’allungamento dei germogli.
Studi recenti su vite (Vitis vinifera) e kiwi (Actinidia deliciosa) hanno confermato che il riscaldamento primaverile regola l’attivazione di geni come EBB1 e GA20ox, favorendo la ripresa vegetativa.
Rilevanza pratica della conoscenza
Comprendere a fondo i meccanismi fisiologici e molecolari che regolano la dormienza nelle specie da frutto a foglia caduca è essenziale non solo per prevedere l’impatto del cambiamento climatico sulla fenologia, ma anche per progettare strategie gestionali adattive ed efficaci.
In un contesto climatico sempre più instabile, questo sapere consente di adattare per tempo le pratiche agricole, selezionare cultivar più resilienti e applicare tecnologie che mitighino gli effetti degli inverni miti o irregolari.
Solo con una solida base tecnica sui processi interni che regolano entrata, mantenimento e uscita dalla dormienza si possono prendere decisioni informate a tutela della produttività, sostenibilità e futuro della frutticoltura nelle zone temperate.
Fonte: Green Network
Fonte immagine: Green Network
María Paz Rosés
Consulente per la gestione del suolo e la nutrizione integrata
Cherry Times - Tutti i diritti riservati