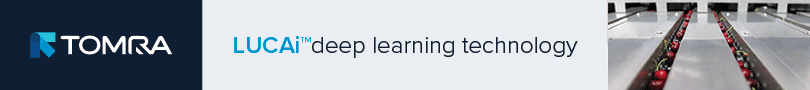La declinazione della ciliegia, ampiamente trattata come frutto ne L’Assaggio 89, in acqueviti e liquori è di lunga tradizione ovunque l’albero venga coltivato. Il potente e complesso aroma di questa drupa è enfatizzato dalla base alcolica originando bevande davvero intriganti
Origine e varietà della ciliegia
Secondo la tradizione, dobbiamo a Lucullo l’introduzione in Italia dell’albero di ciliegio. Era il 64 a.C. quando il generale romano lo portò con sé dall’Asia Minore, dopo una delle sue campagne, precisamente dalla città di Cherasus. Da questo toponimo deriverebbe il nome stesso del frutto che, oggi, nel linguaggio comune, identifica un universo botanico assai più vasto e variegato.
Con il termine “ciliegia” si indicano infatti due specie vegetali e un’infinità di varietà, che danno origine a frutti molto diversi tra loro per forma, colore, sapore, profumo ed epoca di maturazione.
Tutte le ciliegie sono tecnicamente drupe, ossia frutti con nocciolo, ma le loro caratteristiche possono variare in modo sensibile. Il peso del singolo frutto oscilla tra i 2,5 e gli 8 grammi. Il colore può spaziare dal bianco crema al rosso più brillante o scuro, quasi nero. La forma passa da una rotondità quasi perfetta fino a strutture più allungate e ellittiche.
Anche il sapore presenta una gamma ampia: alcune varietà offrono note fresche e dolci, altre sono più acidule o acquose. L’intensità aromatica cambia anch’essa, andando da profili molto ricchi a espressioni più neutre, capaci però di regalare un piacere immediato al palato.
Raccolta e trasformazione
Le ciliegie non maturano tutte insieme. L’epoca della loro raccolta si estende da maggio fino ad agosto, seguendo l’ordine delle cultivar e delle aree geografiche di coltivazione. In questo arco di tempo, si concentrano le attività di chi lavora questo frutto non solo per il consumo fresco, ma anche per la trasformazione artigianale o industriale.
Il profilo aromatico della ciliegia
Dietro il profumo di una ciliegia si cela un’intera architettura di composti volatili. Sono molecole leggere e instabili, ma decisive per definire l’identità sensoriale del frutto. La loro combinazione dà vita a un profilo olfattivo articolato, che varia in base alla varietà, al grado di maturazione e persino al metodo di lavorazione.
Gli esteri dominano la scena aromatica con le loro note fruttate e floreali. Tra i più rappresentativi, l’acetato di etile dona un profumo di frutta fresca, mentre il butanoato ed esanoato di etile richiamano la frutta matura con sfumature esotiche. Anche il metil-2-butanoato e l’esanoato di metile contribuiscono con sensazioni rotonde, che ricordano l’estate e i frutti tropicali.
Accanto agli esteri, le aldeidi introducono una dimensione più verde ed erbacea, talvolta con accenti mandorlati. L’esanale, ad esempio, sprigiona sentori freschi e vegetali, mentre la benzaldeide, presente soprattutto in amarene e marasche, regala il classico aroma di mandorla e marzapane. Il furfurale, invece, aggiunge una nota calda, che ricorda il pane tostato e la vaniglia.
Gli alcoli volatili rafforzano la freschezza del bouquet. L’1-esanolo contribuisce con sfumature erbacee, mentre l’1-pentanolo introduce delicate note floreali. Il feniletanolo, noto per il suo profumo di rosa e miele, completa il ventaglio.
Componenti aromatici e varietà
A rendere l’aroma della ciliegia ancora più stratificato intervengono i chetoni, come il β-ionone, che evoca la viola e i frutti rossi, e il damascenone, noto per il suo profilo intensamente floreale. I terpeni, altro gruppo aromatico di rilievo, conferiscono toni speziati, balsamici e floreali. Linalolo, geraniolo e α-terpineolo sono responsabili di note che spaziano dalla lavanda agli agrumi, dai fiori bianchi alla resina.
Non mancano componenti più discreti ma incisivi, come i composti solforati. Pur presenti in tracce, influenzano le sfumature speziate e tostate con un apporto sottile ma percettibile, come nel caso del dimetil disolfuro. Infine, i lattoni arricchiscono la componente dolce e cremosa dell’aroma: il γ-decalattone suggerisce pesca e albicocca, mentre il γ-nonalattone introduce una sensazione che ricorda cocco e vaniglia.
Le differenze tra le varietà di ciliegia si esprimono proprio attraverso la diversa concentrazione di queste molecole. Le ciliegie dolci (Prunus avium) presentano una maggiore presenza di esteri e terpeni, che conferiscono un carattere più floreale. Le amarene (Prunus cerasus) mostrano un profilo più ricco di aldeidi e benzaldeide, con predominanti note mandorlate e di frutta matura.
Le marasche, utilizzate per la produzione del maraschino, si distinguono per l’intensità aromatica, dovuta a elevate quantità di benzaldeide e terpeni. Le visciole, infine, si collocano a metà strada tra le dolci e le amarene, mostrando un equilibrio tra note fresche e mandorlate, con un ruolo importante del furfurale e del feniletanolo.
L’acquavite di ciliegie
La produzione dell’acquavite di ciliegie è un processo che richiede rigore tecnico e sensibilità sensoriale. Il primo passaggio fondamentale riguarda l’ammostamento, per il quale è importante predisporre un sistema capace di eliminare i noccioli. Tuttavia, non tutti vanno scartati: il 5% deve essere frantumato e reintrodotto nel mosto in fermentazione per arricchirlo di precursori aromatici.
Il mosto di ciliegia è naturalmente ricco di zuccheri, in una percentuale che va dall’8 al 16%, e ciò consente di ottenere fermentazioni in grado di sviluppare alcolicità comprese tra il 6,5 e il 10%. Inoltre, la composizione acidica è tale da fornire una buona stabilità microbiologica: il pH, grazie alla presenza naturale di acidi malico, succinico e citrico, si aggira attorno al valore di 3,2 e non necessita in genere di alcuna correzione esterna.
La distillazione rappresenta un momento delicato e cruciale. Deve essere condotta con lentezza e precisione, per preservare e concentrare l’aroma fine e caratteristico della ciliegia. Solo attraverso una distillazione attenta si può ottenere un’acquavite che sia davvero espressiva e rispettosa della materia prima da cui proviene.
Una volta ottenuta, l’acquavite va lasciata maturare. L’affinamento ideale avviene in vetro per un periodo di dieci-dodici mesi, dei quali almeno due devono seguire la riduzione del grado alcolico. In questo tempo, il distillato si stabilizza, acquisisce rotondità e sviluppa un profilo olfattivo seducente.
Degustazione e usi
Curiosamente, questa fragranza, tanto apprezzata, tende a deteriorarsi se il prodotto viene invecchiato in legno. Al contrario, mantiene tutta la sua integrità se conservato in bottiglia, dove continua a esprimersi in modo limpido e costante.
Il momento della degustazione, infine, merita attenzione. Servita a una temperatura di circa 5°C, l’acquavite di ciliegie si rivela in tutta la sua delicatezza e attrattiva. È una bevanda che accompagna con eleganza qualsiasi ora del pomeriggio o della sera, offrendo un’esperienza piacevole e raffinata.
Particolarmente indicata come digestivo, soprattutto nelle giornate estive, trova anche impiego in cucina. Tra gli usi classici, spicca quello nella preparazione della fonduta, dove viene impiegata come aromatizzante per arricchire e personalizzare la ricetta con una nota fruttata e suadente.
Il liquore di ciliegia
La produzione di liquori a base di ciliegia è una pratica che unisce tradizione artigianale e innovazione tecnologica. Dietro ogni bottiglia di maraschino, ratafià o cherry brandy, c’è un processo che ha come obiettivo quello di preservare e valorizzare l’aroma delicato e volubile di uno dei frutti più amati dell’estate.
Tutto comincia con la selezione della materia prima. La ciliegia utilizzata per i liquori deve essere ben matura, ricca di zuccheri e con un profilo aromatico intenso. In alcuni casi si usano varietà specifiche, come la marasca per il maraschino o le amarene per la visinată. Una volta raccolte, le ciliegie possono essere lavorate fresche o surgelate, a seconda delle esigenze produttive.
La prima fase tecnologica è l’infusione. Le ciliegie, intere o denocciolate, vengono messe a macerare in alcol neutro. Questo processo, che può durare da pochi giorni a diverse settimane, consente l’estrazione dei composti aromatici, dei pigmenti naturali e, se presenti, delle note mandorlate del nocciolo.
Al termine dell’infusione, si procede alla separazione alla quale segue la standardizzazione alcolica e zuccherina, che viene effettuata per portare il liquore a un contenuto di zuccheri oscillante tra il 10% e il 35% e la ricchezza alcolica tra 25 e 35 % vol.
Alcuni produttori ricorrono anche a tecniche di aromatizzazione controllata, impiegando estratti naturali o infusioni complementari (come spezie o erbe). In fase finale, può essere previsto un breve affinamento in acciaio o vetro per stabilizzare il prodotto prima dell’imbottigliamento.
Tipologie di acquaviti
- Kirsch o Kirschwasser, tipico della Germania, Svizzera, Francia (Alsazia) e Austria.
- Kirsch de Fougerolles, Aoc francese specifica della regione di Fougerolles.
- Schwarzwälder Kirschwasser, denominazione tipica della Foresta Nera (Germania).
- Zuger Kirsch, distillato di ciliegia tipico del Canton Zugo (Svizzera).
- Basler Kirsch, prodotto nel Canton Basilea (Svizzera).
- Rigi Kirsch, distillato svizzero della regione del Monte Rigi.
- Luzerner Kirsch, tipico del Canton Lucerna (Svizzera).
- Vogtländischer Kirschbrand, distillato della regione del Vogtland (Germania).
- Ciliegia Acquavite IG, Indicazione Geografica Italiana per distillati di ciliegia.
Tipologie di liquori
- Ceresella, tipico italiano della Campania e del Sud, ma con eccezioni di rilievo al Nord dove esistono versioni generate con base grappa.
- Cherry Brandy, termine generico per liquori di ciliegia, spesso aromatizzati con mandorla.
- Maraschino, liquore incolore ottenuto da ciliegie marasche, tipico della Dalmazia e del Veneto.
- Maraschino di Zara, famosa denominazione croata.
- Ginjinha o Ginja, liquore portoghese prodotto con ginja (varietà di amarena).
- Ratafià di ciliegie, liquore dolce italiano tipico di Piemonte e Abruzzo, ottenuto con infusione di ciliegie e spezie.
- Heering Cherry Liqueur, famoso liquore danese a base di ciliegie e spezie, usato nei cocktail come il Singapore Sling.
- Guignolet, liquore francese prodotto con guigne (ciliegie selvatiche).
- Cherry Bounce, antico liquore artigianale anglosassone a base di ciliegie, zucchero e brandy/whisky.
- Visinată, liquore rumeno a base di amarene macerate in alcol.
- Vișinată de Transilvania IG, liquore di amarene della Transilvania (Romania).
Fonte immagine: DonnaD
Luigi Odello
Presidente Centro Studi Assaggiatori - Segretario accademico Iasa
Cherry Times - Tutti i diritti riservati