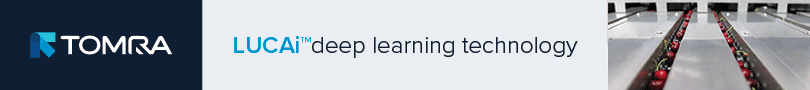La dimensione del frutto è una caratteristica fondamentale sia per l’accettazione commerciale che per l’efficienza post-raccolta.
Sebbene il diametro medio dei cultivar commerciali oscilli tipicamente tra 20 e 30 mm, le varietà più recenti sviluppate nei programmi di miglioramento genetico superano abitualmente i 30 mm, riflettendo un progresso significativo nella selezione di genotipi di calibro maggiore.
Lo sviluppo della dimensione del frutto è un processo fisiologico complesso, regolato da un programma noto come crescita doppio sigmoide: un modello che definisce una sequenza precisa di cambiamenti molecolari, ormonali e strutturali.
Questa sequenza dà forma all’anatomia del frutto che, nel caso della ciliegia, corrisponde a quella di una drupa.
Questo tipo di frutto è composto da tre strati distinti: una buccia esterna o epicarpo; una polpa carnosa, il mesocarpo; e un endocarpo legnoso interno, che racchiude il seme.
L’obiettivo biologico di questo programma di sviluppo è l’ottimizzazione del mesocarpo, poiché la sua dimensione e composizione determinano la qualità finale del frutto.
Fase I: La proliferazione cellulare
Questa fase inizia subito dopo l’impollinazione e la fecondazione del fiore, con una durata di circa 10–25 giorni.
Durante questo periodo, il piccolo frutto, ancora verde per via dell’attività fotosintetica, si dedica a un unico e decisivo processo fisiologico: la proliferazione cellulare per mitosi.
L’obiettivo di questa fase non è aumentare visibilmente le dimensioni, ma costruire l’“impalcatura” cellulare del frutto.
La quantità finale di cellule generate nel mesocarpo (la polpa) riflette in modo quasi matematico il calibro massimo che la ciliegia potrà raggiungere.
I due motori fisiologici che alimentano questo processo sono:
Una regolazione ormonale precisa – Il processo è guidato da un cocktail ormonale in cui le auxine (IAA) e le giberelline (GAs) stimolano senza sosta la divisione cellulare (attivando cicline e CDK), mentre l’ormone inibitore, l’acido abscissico (ABA), resta soppresso.
La creazione di infrastrutture vascolari – In parallelo, xilogènesi e floemogènesi costruiscono la rete di xilema e floema, indispensabile per nutrire la crescita.
La capacità di questa rete, definita interamente in questa fase, limiterà lo sviluppo successivo.
Il principio del numero di cellule
Il principio secondo cui il numero di cellule determina il potenziale di calibro è stato misurato con precisione.
Esiste una correlazione diretta tra il numero di strati cellulari del mesocarpo e il diametro finale del frutto.
Lo studio di Olmstead et al. (2007) ne offre la dimostrazione empirica: la differenza di calibro tra la piccola ciliegia selvatica ‘NY 54’ (~28 strati cellulari) e la grande ‘Selah’ (>75 strati) non è casuale, ma conseguenza diretta dell’attività mitotica programmata nei loro genomi per questa fase.
Questo numero di cellule non è una variabile dipendente dalla gestione agronomica, ma un carattere genetico altamente ereditabile.
È il potenziale intrinseco di ogni varietà, obiettivo prioritario dei programmi di miglioramento genetico per ottenere ciliegie di calibro maggiore.
La Fase I, quindi, non solo avvia la crescita: stabilisce i limiti genetici del calibro finale.
Fase II: Indurimento del nocciolo
Dopo la proliferazione, il frutto entra in una fase di apparente latenza che dura 10–20 giorni.
La crescita esterna si ferma quasi del tutto e il colore passa dal verde a un giallo tenue.
Tuttavia, questo arresto della crescita è solo apparente: internamente, l’energia si concentra in processi cruciali.
Ormonalmente, i livelli di ABA, pur ancora bassi, iniziano a salire, preparando il frutto alla maturazione finale.
I due eventi chiave di questa fase sono:
La chimica dell’indurimento – Il processo centrale è la lignificazione dell’endocarpo.
Le cellule di questo strato sintetizzano e depositano lignina —un polimero fenolico complesso— nelle pareti cellulari.
Catalizzato da enzimi come perossidasi e lacasi, ciò porta alla formazione di un nocciolo estremamente duro e resistente, che protegge l’embrione.
Crisi e passaggio nel trasporto vascolare – La crescente rigidità del nocciolo esercita pressione fisica sul sistema vascolare, provocando cavitazione (rottura) di molti vasi dello xilema e interrompendo il flusso di acqua attraverso questa via.
Di conseguenza, il frutto è costretto a una transizione fisiologica, diventando sempre più dipendente dal floema per l’importazione di acqua e zuccheri.
Fase III: Espansione finale
Questa è la fase finale e più spettacolare dello sviluppo, che dura 15–25 giorni fino alla raccolta.
Il frutto vive una seconda e rapida fase di crescita esponenziale, non più creando nuove cellule, ma espandendo quelle già presenti.
Alimentate da un massiccio accumulo di acqua e zuccheri nelle vacuole, le cellule si rigonfiano drasticamente.
In questa fase si definiscono tutti gli attributi chiave che rendono la ciliegia pronta per la raccolta.
Sviluppo di sapore e colore – Biochimicamente, il frutto si trasforma.
Si accumulano grandi quantità di antocianine nella buccia, i pigmenti responsabili del tipico colore rosso intenso o mogano.
Allo stesso tempo, il sapore evolve verso il punto ottimale: gli zuccheri solubili (soprattutto D-glucosio) aumentano, mentre la concentrazione di acidi organici diminuisce, creando il perfetto equilibrio dolce-acido.
Modifica della consistenza: ammorbidimento controllato – Anche la consistenza cambia con una progressiva perdita di compattezza.
Questo ammorbidimento è un processo controllato di disassemblaggio della parete cellulare, orchestrato dall’ABA, che qui raggiunge il suo picco.
L’ABA attiva l’espressione di geni che codificano per enzimi idrolitici chiave:
Poligalatturonasi (PG) e Pectina metilesterasi (PME) – Degradano le pectine, il “cemento” che unisce le cellule.
Espansine – Allentano la rete di cellulosa ed emicellulosa, aumentando la viscoelasticità della parete e permettendo alla polpa di diventare morbida e succosa.
Il rischio associato: la fisica del cracking – Questa rapida espansione non è priva di rischi.
L’accumulo di zuccheri nella vacuola crea un potenziale osmotico molto negativo che attrae acqua per osmosi, generando forte pressione di turgore.
Il cracking si verifica quando questa pressione interna supera il limite di elasticità dell’epidermide: la buccia, sottoposta a tensione estrema, non riesce ad allungarsi ulteriormente e si rompe, compromettendo qualità e integrità del frutto.
Conclusione: genetica vs fisiologia
Il viaggio della ciliegia attraverso queste tre fasi rivela una lezione fondamentale sulla biologia del calibro.
La dimensione finale che osserviamo e apprezziamo non è il risultato di un unico processo, ma di una dualità essenziale:
La Fase I stabilisce il potenziale genetico del calibro: attraverso la proliferazione cellulare si fissa un numero massimo di cellule, che funge da progetto architettonico del frutto.
Questo numero è un tratto intrinseco di ogni varietà, definito dal DNA.
La Fase III, invece, realizza fisiologicamente quel potenziale: tramite l’espansione cellulare, e sotto l’influenza di fattori come irrigazione e nutrizione, il frutto “riempie” il potenziale stabilito nella prima fase.
La Fase II funge da ponte indispensabile tra la creazione del potenziale e la sua realizzazione.
La conclusione è chiara: il vero segreto di un grande calibro non sta nel “gonfiare” le cellule nella fase finale, ma nella capacità genetica di crearne un numero maggiore fin dall’inizio.
E questo apre una domanda che sarà la premessa per la prossima analisi: se il numero di cellule è il fattore genetico decisivo, quali geni specifici agiscono da direttori d’orchestra nella Fase I?
Quali sequenze di DNA comandano a una ciliegia di produrre il doppio di cellule rispetto a un’altra?
La risposta ci porterà nel mondo affascinante della genomica e del miglioramento di precisione, un viaggio nel cuore del DNA del ciliegio che esploreremo nella prossima analisi.
Fonte immagine: SL Fruit Service
Jesus Alonso
Elmundocereza
Cherry Times - Tutti i diritti riservati